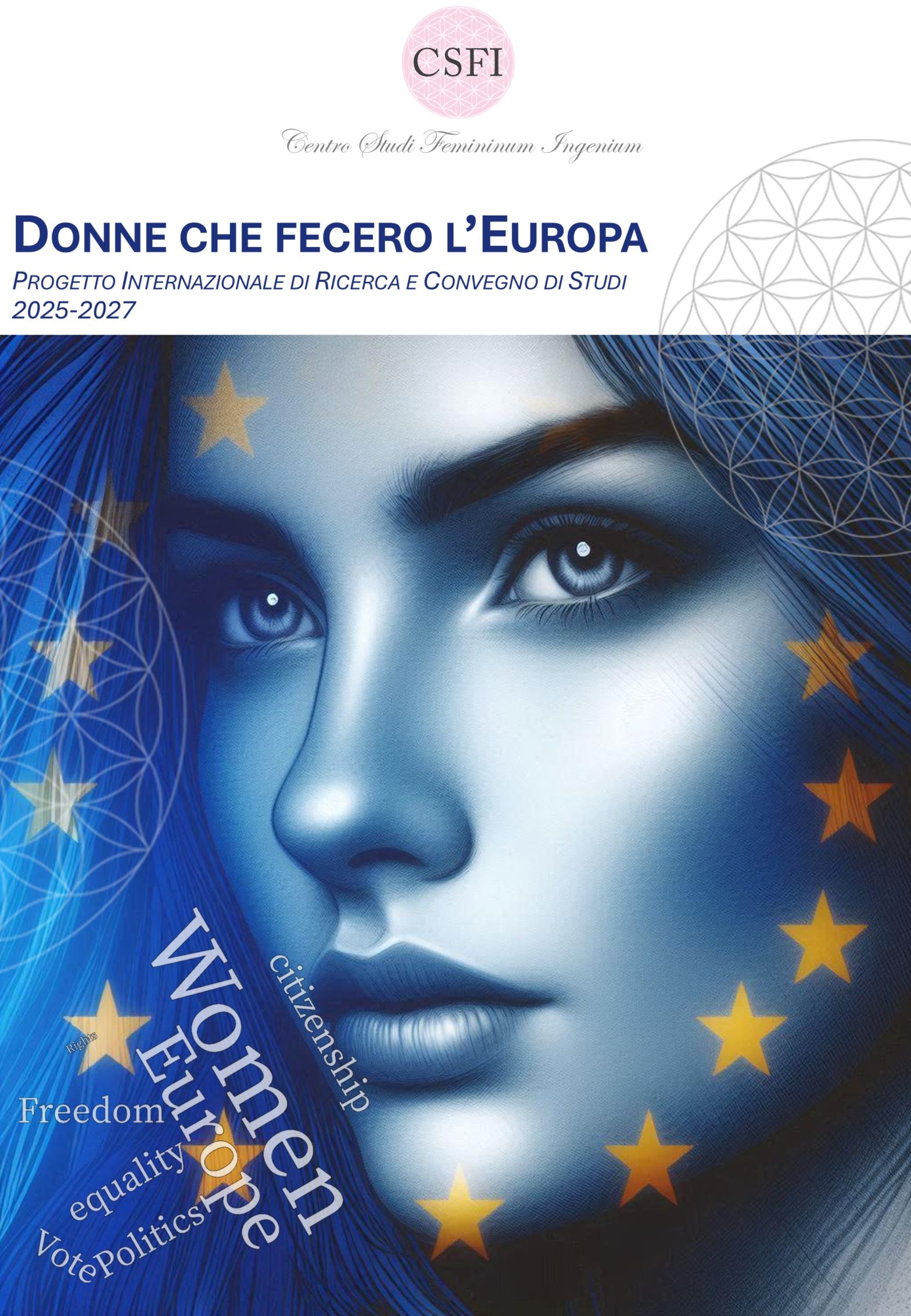Progetto internazionale di ricerca e Convegno di studi
Donne che fecero l’Europa.
Il contributo delle donne alla stesura delle costituzioni degli stati europei è un tema complesso e spesso sottovalutato. Storicamente, le donne hanno avuto un ruolo limitato nel processo formale di redazione delle costituzioni, in gran parte a causa delle barriere sociali, culturali e legali che hanno limitato la loro partecipazione politica. Il Centro Studi Femininum Ingenium e l’Università degli Studi “Guglielmo Marconi” hanno già affrontato congiuntamente il tema delle Madri della Patria, ovvero di quelle importanti figure femminili della storia politica italiana, che hanno saputo tradurre in azione concreta la propria formazione politica. Sulla base di questa brillante esperienza, si propone di estendere il campo della ricerca al consesso europeo, anche in funzione del prossimo 70° Anniversario della firma del Trattato di Roma del 1957, definito come l’atto di nascita della grande famiglia europea.
Obiettivi. La ricerca si propone la valorizzazione delle figure femminili che hanno contribuito alla nascita delle democrazie nei vari Stati europei. Il contributo femminile nella creazione e nello sviluppo della cittadinanza europea e dei diritti fondamentali sanciti nei Trattati dell’Unione Europea è stato, infatti, significativo e spesso sottovalutato. Le donne hanno svolto un ruolo cruciale in vari ambiti, giuridico, politico, sociale, economico, ecc., contribuendo a plasmare un’Europa più inclusiva e giusta.
Fin dall’inizio del processo di integrazione europea, le donne hanno partecipato attivamente alla politica. Figure come Simone Veil, prima presidente del Parlamento Europeo, hanno lottato per i diritti delle donne e per l’uguaglianza di genere all’interno delle istituzioni europee. Il loro impegno ha portato a un riconoscimento formale dei diritti femminili nei trattati e nelle politiche europee.
Le donne hanno avuto un ruolo fondamentale nella promozione e nella difesa dei diritti umani in Europa, contribuendo così alla redazione della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, adottata nel 2000. Questa carta include articoli specifici sulla parità di genere e la non discriminazione, che hanno rafforzato il quadro giuridico per la protezione dei diritti delle donne.
Negli ultimi decenni, l’Unione Europea ha iniziato a integrare la prospettiva di genere nelle sue politiche e programmi. L’adozione di strategie per l’uguaglianza di genere e l’empowerment delle donne ha portato a misure concrete volte a migliorare la posizione delle donne nella società, nel lavoro e nella vita pubblica. Queste politiche sono il frutto delle basi gettate dalle donne che hanno contribuito a costruire le democrazie europee e l’Europa stessa, fondando i principi di una vera cittadinanza europea attraverso l’educazione e la ricerca.
Finalità. Finalità del progetto è quella di evidenziare il sostrato culturale comune, analizzato con differenti lenti e approcci disciplinari che potranno variare dalla filosofia alla sociologia, dalla storia alla scienza politica e giuridica, che si radica nell’Europa intesa come unità politica attraverso il pensiero femminile e la sua base relazionale. Il presupposto teorico poggia sulla considerazione che gli apporti contenutistici ed analitici delle donne in ciascuna costituzione nazionale possono essere considerati la base per la costruzione di una vera unione europea che non sia solo un mero accordo economico-politico tra stati, ma una reale costruzione identitaria e culturale. Le lotte delle donne per i diritti civili e politici hanno, infatti, portato all’inclusione di principi fondamentali di uguaglianza e non discriminazione nelle Costituzioni nazionali. Questi principi sono diventati un fondamento comune per le nazioni europee, contribuendo alla costruzione di una concezione condivisa di diritti umani.
L’inclusione delle donne nelle istituzioni e nel processo politico ha enfatizzato, inoltre, l’importanza della diversità. Questo ha portato a una visione più ampia dell’identità europea, che riconosce e celebra le differenze culturali, sociali e di genere, favorendo il senso di appartenenza a una comunità più ampia.
Partecipazione internazionale. Aderiscono al progetto studiosi e docenti di varie università europee: Spagna, Grecia, Francia, Austria, Germania, Polonia.
Hanno aderito al gruppo di lavoro docenti e studiose delle seguenti Università italiane:
- Università degli Studi “Guglielmo Marconi” – partner del progetto;
- Sapienza Università degli Studi di Roma;
- Università degli Studi di Roma Tor Vergata;
- Università degli Studi di Roma Tre;
- UnitelmaSapienza;
- Pontificia Università Lateranense;
- Università eCampus.
Tematiche. Le tematiche che saranno affrontate in chiave internazionale e multidisciplinare sono:
- Parole chiave delle donne. Focus sui temi principali affrontati dal pensiero e dall’azione femminile nell’ambito della formazione costituzionale dei singoli paesi e ricognizione dell’eredità concettuale e pragmatica trasferita nelle Carte europee.
- Linee fondative. Ricerca, evidenziazione e sviluppo delle linee fondative del pensiero femminile, facendo riferimento anche al pensiero cristiano, rintracciabili nell’opera e negli scritti delle donne costituenti e nelle politiche europee, al fine di comprendere se e quanto si possa parlare attualmente di Europa in chiave di comune identità di pensiero e di cultura, prescindendo dal mero dato economico.
- Movimenti per i diritti delle donne. Le lotte per i diritti civili e politici delle donne nel XIX e XX secolo, hanno influenzato il linguaggio e i principi delle Costituzioni. Le rivendicazioni per l’uguaglianza di genere e i diritti delle donne hanno infatti spesso portato anche ad importanti riforme costituzionali.
- Costituzioni moderne. Le donne spesso hanno avuto un ruolo attivo nei processi di redazione delle costituzioni nel XX secolo, soprattutto nei paesi che hanno vissuto transizioni democratiche, come ad esempio la Spagna dopo la dittatura di Franco o l’Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale. Le donne sono state coinvolte nei dibattiti pubblici e nelle assemblee costituenti, contribuendo a garantire che i diritti delle donne fossero inclusi nelle nuove costituzioni.
- Casi di studio. Ciascun partecipante potrà prendere in esame specifici casi di studio, tracciando profili femminili tematici ed orientati alla ricostruzione filologica del pensiero e dell’azione politica. A mero titolo di esempio, la già citata Simone Veil, prima Presidente donna del Parlamento Europeo; Ursula Hirschmann, fondatrice del Movimento Federalista Europeo insieme ad Altiero Spinelli; in Finlandia, la prima donna a essere eletta nel Parlamento nel 1907, Alexandra Gripenberg, ha lavorato per l’uguaglianza di genere e il diritto di voto; in Svezia, il movimento per i diritti delle donne ha influenzato profondamente la legislazione e le riforme costituzionali nel XX secolo; in Germania, il “Grundgesetz” -Legge Fondamentale- del 1949 ha incluso principi di uguaglianza di genere.
- Prospettiva comparatistica. Uno degli obiettivi del progetto è quello di analizzare e confrontare, in chiave di partecipazione femminile, diversi sistemi giuridici al fine di comprendere meglio il funzionamento del diritto nelle varie culture e società. In particolare, quindi, nella parte giuridica della ricerca, sarà incentivata l’adozione di una prospettiva comparatistica quale metodo di studio che si basa sull’idea che i sistemi giuridici non siano isolati, ma influenzati reciprocamente attraverso scambi culturali, economici e politici. Identificare e studiare le differenze e le somiglianze tra i vari sistemi giuridici, supportando la ricerca con contributi provenienti da altre discipline, come la sociologia, l’antropologia, l’economia e la storia per arricchire l’analisi giuridica, è alla base della comprensione delle diverse soluzioni normative.
- Riconoscimento e rappresentanza. Il riconoscimento dei diritti delle donne nelle Costituzioni europee è spesso il risultato di anni di attivismo e pressione da parte delle donne, che spesso hanno giocato un ruolo cruciale nel garantire che le Costituzioni fossero interpretate in modo da promuovere l’uguaglianza di genere.
- Il futuro. il progetto qui presentato ha un obiettivo non soltanto meramente di ricostruzione storica, ma possiede anche un afflato sul presente e sul futuro. Si propone anche di offrire spunti di riflessione in merito, ad esempio, alla rilevanza attuale per le politiche di genere dei principi inclusi nelle Costituzioni nazionali grazie al contributo delle donne, ponendo anche l’attenzione alle possibili sfide attuali e future.
Durata. Il progetto di ricerca avrà durata biennale e si concluderà con un Convegno di Studi dedicato alla presentazione dei risultati della ricerca. Il Convegno si svolgerà il 25 marzo 2027 in una sede istituzionale da definire.
Mostra Europee. A far da cornice al Convegno, si propone l’allestimento di una Mostra dedicata alle principali figure femminili che hanno contribuito alla costruzione degli stati nazionali europei e alla fondazione di un comune sentire culturale europeo. Europee sarà costituita da una ventina di vele roll up con i volti delle principali protagoniste accompagnate da brevi cenni biografici.
Comitato Scientifico Promotore. Fabrizia Abbate, Angela Ales Bello, Agata C. Amato, Paolo Armellini, Veronica Balaji, Sandra Berivi, Luca Bugada, Fiammetta Campagnoli, Maria Novella Campagnoli, María Cruz Díaz de Terán Velasco, Massimo Farina, Roberta Fidanzia, Angelo Gambella, Antonio Grassi, Roberta Iannone, Ilaria Iannuzzi, Georgios Katzantonis, Raffaella Leproni, María Ángeles Llorca Tonda, María José López Rey, Maria Rita Mottola, Ilaria Pagani, Anna Maria Pezzella, Giorgia Pinelli, Ulrike Haider Quercia, Maria Grazia Rodomonte, Maria Teresa Russo, Tommaso Valentini.
Pubblicazione scientifica. A conclusione del progetto e come fase finale dello stesso, sarà curata la pubblicazione scientifica dei risultati di studio e ricerca e del Convegno, presumibilmente entro il 2028. La pubblicazione sarà inserita in Femininum Ingenium. Collana di Studi sul genio femminile, del Centro Studi Femininum Ingenium.
Collaborazioni e Patrocini. Saranno attivate collaborazioni istituzionali con enti privati (associazioni, riviste, università) e con enti pubblici per la concessione di Patrocini morali.